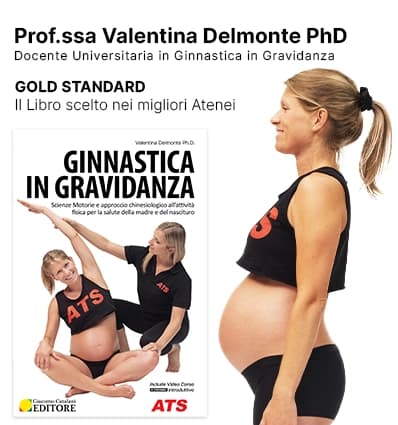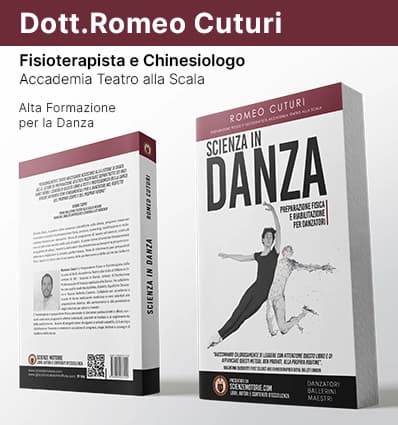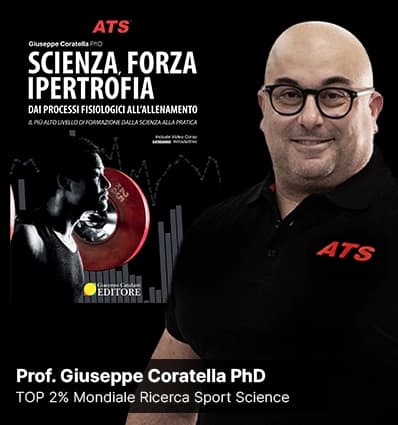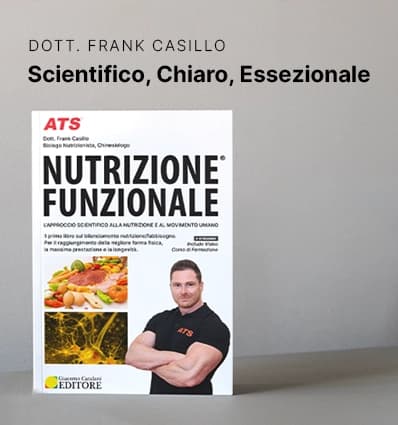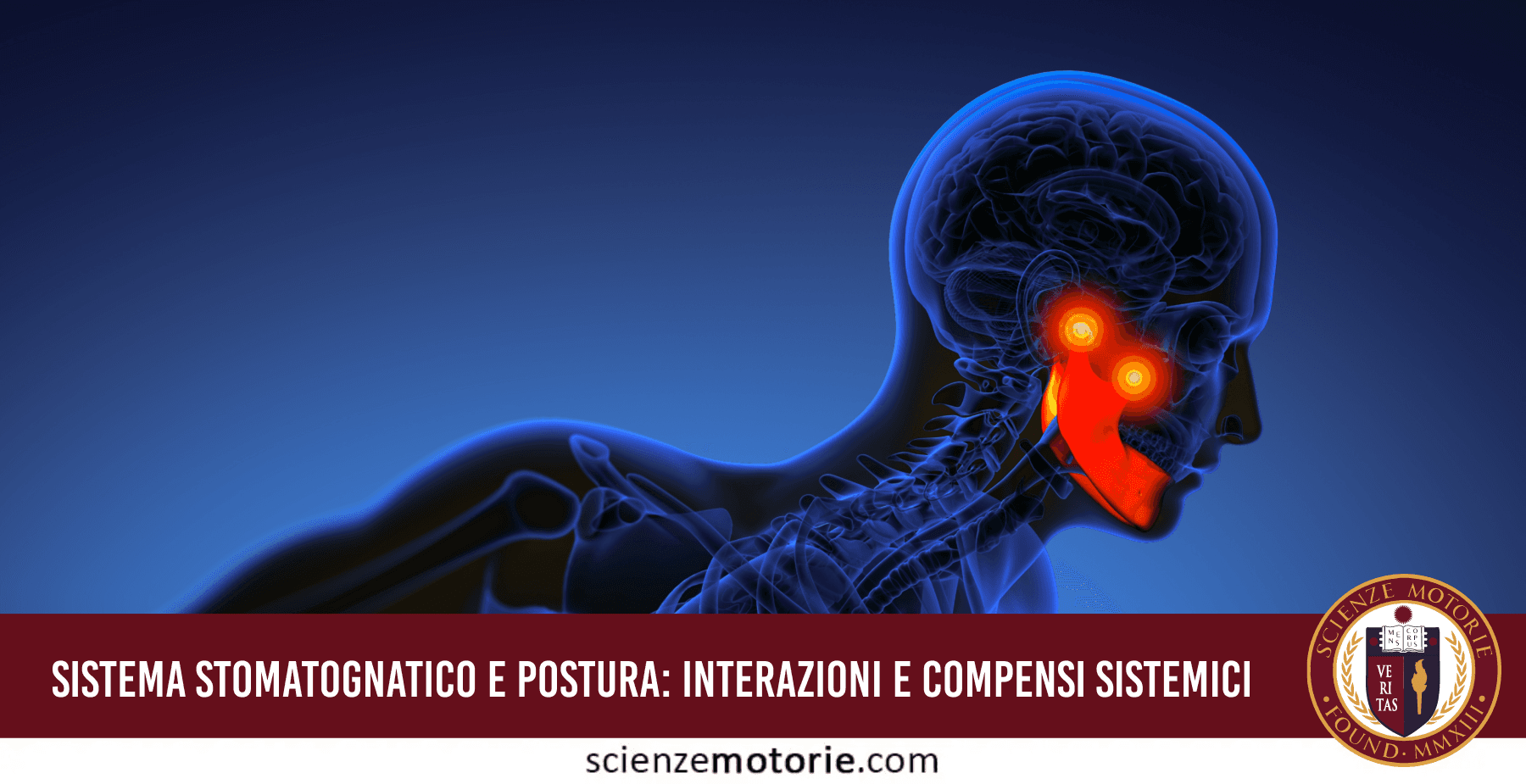La speed endurance, termine che tradotto letteralmente significa resistenza alla velocità, è un allenamento anaerobico lattacido, in cui si ripetono prove a intensità massimale o quasi massimale (superiore al VO2max), separate da un periodo di recupero passivo.
La durata delle prove ripetute e del recupero, il numero di ripetizioni e l’intensità d’esercizio permettono la classificazione della speed endurance in due categorie: speed endurance production (SEP) e speed endurance maintenance (SEM) (Reilly & Bangsbo, 1998).
La SEP prevede ripetizioni di durata minore di 40 secondi, eseguiti a un’intensità massimale o quasi massimale (70-100% della massima velocità), con un recupero relativamente lungo, ovvero maggiore di cinque volte la durata del lavoro (il lavoro:recupero è ≥1.5).
Mentre, la SEM include ripetizioni tra 5-90 secondi con un breve recupero, ossia minore uguale a tre volte la durata della fase di lavoro (il lavoro:recupero è ≤ 1:3); l’intensità d’esercizio è sub-massimale, quindi minore rispetto alla SEP (70-100% della massima velocità).
L’obiettivo della SEP è ottenere la massima performance a ogni prova ripetuta, mentre quello della SEM di accumulare fatica. Quindi, questo tipo di training ricerca adattamenti fisiologici a livello del sistema anaerobico lattacido, con la SEM che ha come target principale la capacità lattacida e la SEP la potenza lattacida. Il tutto è semplificato e spiegato in modo chiaro nella tabella sotto riportata (figura 1), estrapolata dalla Review sulla speed endurance di F.M. Iaia e J. Bangsbo (2010).
| Type of anaerobic | Exercise intensity (% of maximum speed) | Duration of exercise (s) | Duration of recovery | N° of repetitions |
|---|---|---|---|---|
| Speed | 100 | 2-10 | 50-100s | 5-20 |
| Speed endurance production | 70-100 | 10-40 | >5 times exercise duration | 3-12 |
| Speed endurance maintenance | 50-100 | 5-90 | 1-3 times exercise duration | 2-25 |
Figura 1 – Tipologie di allenamento anaerobico (F.M. Iaia, J. Bangsbo, 2010).
Adattamenti fisiologici
Gli adattamenti fisiologici alla speed endurance, ossia le modifiche fisiologiche dell’organismo che permettono di ottenere una migliore performance generale (con conseguenza diretta sulla performance specifica), sono prevalentemente i seguenti (F.M. Iaia, J. Bangsbo, 2010):
- Maggiore attività degli enzimi glicolitici e ossidativi.
- Miglioramento nella regolazione del PH.
- Minore consumo energetico durante l’esercizio fisico.
- Cambiamenti nella pompa sodio-potassio, che permettono di preservare più a lungo l’eccitabilità muscolare e lo sviluppo della forza.
Tuttavia, i fattori che contribuiscono ai miglioramenti di performance potrebbero essere anche altri. Soprattutto, occorre evidenziare che questo tipo di training permette di mantenere la fitness aerobica nonostante il basso volume d’allenamento, andando a migliorare la performance di resistenza tramite gli adattamenti di cui sopra, senza modifica dei parametri di fitness aerobica (in primis VO2max e attività degli enzimi ossidati).
Miglioramento di performance specifica
In un recente studio del 2015 (Iaia FM et al.) su giovani calciatori professionisti, è stato visto che la SEP migliora la capacità di ripetere sprint (RSA) e la performance nell’esercizio intermittente ad alta intensità. Mentre la SEM migliora l’abilità del muscolo di tollerare la fatica e di mantenere la velocità durante l’esercizio massimale di tipo ripetuto o continuo di breve durata. I miglioramenti sono stati rilevati nonostante la riduzione del volume d’allenamento di circa il 20%.
Speed endurance “a secco” e con la palla
Lo svolgimento di small-sided games 1v1 e 2v2, con la manipolazione delle variabili per ottenere un’altissima intensità di lavoro (massimale o quasi massimale) permette di eseguire allenamenti specifici di speed endurance.
La manipolazione della ratio lavoro:recupero, secondo le specifiche sopraindicate, permetterà di lavorare in modalità SEP o SEM. Però, la speed endurance, tramite esercizi di corsa, generali e aspecifici, permette di ottenere miglioramenti in una modalità maggiormente controllabile e probabilmente più efficace.
Alcune linee guida per implementare nei programmi d’allenamento la speed endurance, sono le seguenti (modificate da T. Strudwick, 2016):
- Intensità massima o vicina alla massima.
- Numero di ripetizioni tra 4 e 12.
- SEP lavoro:recupero ≥1:5.
- SEM lavoro:recupero ≤ 1:3.
- Svolgere 1-2 sessioni a settimana.
- Il giorno prima e dopo il match non eseguire allenamenti di speed-endurance.
- Incrementare il numero di ripetizioni, partendo da 4, negli allenamenti successivi, con gradualità e progressione del carico.
- Il giorno ideale per lo svolgimento di questo tipo di training è tre giorni prima del match.
Seguire queste linee guide permette di massimizzare gli adattamenti fisiologici, evitare overreaching disfunzionale e/o overtraining e ridurre il rischio d’infortunio.
Dunque, in quest’articolo abbiamo analizzato la speed endurance e la sua importanza per il miglioramento della performance del calciatore. Esprimendo, come di consueto, la mia opinione a chiusura dell’articolo, ritengo che la speed endurance, sia nella modalità SEP che SEM, è fondamentale per il miglioramento della performance del calciatore, generale e specifica, e soprattutto permette di ottenere miglioramenti con un tempo minimo d’allenamento, enfatizzando il concetto di efficienza dell’allenamento, fondamentale nel calcio professionistico, in cui gli impegni agonistici ravvicinati limitano al massimo il tempo disponibile per l’allenamento fisico. Infine, nella scelta tra allenamento con la palla o a secco, ritengo che nello speed endurance training occorra prediligere (non scegliere unicamente) la seconda modalità, poiché potrebbe condurre a risultati maggiori e più controllabili.