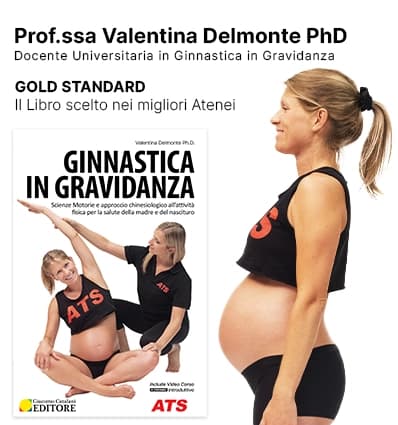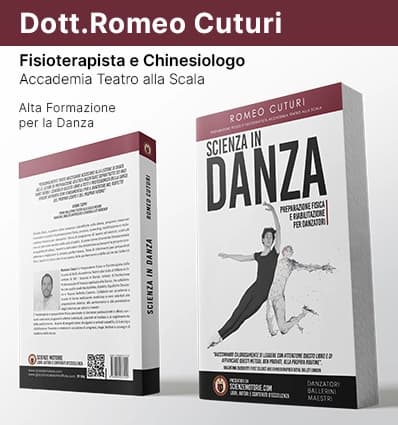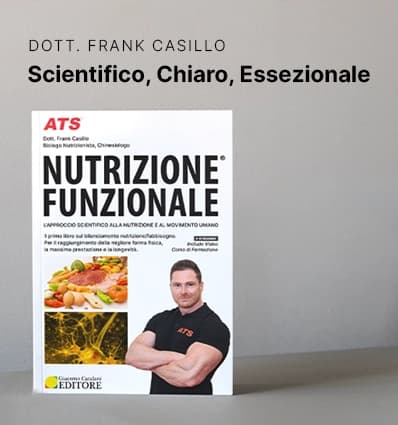Il Concetto di carico interno e carico esterno nel calcio
Il gioco del calcio allo stato attuale richiede una notevole applicazione di differenti aspetti per analizzare la performance fisica e tecnico tattica del giocatore.
Il gioco in sé rimane uguale, dai dilettanti ai professionisti, le regole sono le stesse e così come il numero di partecipanti. Ciò che cambia notevolmente sono le prestazioni fisiche e le richieste imposte da tale sport.
Già dal 1994 Jens Bangsbo, ha evidenziato le relazioni tra le componenti fisiologiche che ne caratterizzano la performance e come interagiscono tra di esse.
Il Carico Interno e Il Carico Esterno
Nel caso dell’allenamento, il carico di allenamento può essere classicamente definito come: “la somma del lavoro richiesto all’atleta, ovvero l’insieme delle sollecitazioni funzionali provocate da quest’ultimo in un determinato periodo di tempo”. Può essere suddiviso in carico interno e carico esterno (da non confondere con gli stimoli: più stimoli formano il carico totale dell’allenamento).
- Carico interno: è rappresentato dalla somma degli stress che subisce l’organismo sottoposto ad un carico esterno; è strettamente soggettivo.
- Carico esterno: è la quantificazione oggettiva dei mezzi utilizzati nell’allenamento (per es. km percorsi, velocità di percorrenza, pendenza, tipo di recupero).
Per migliorare la prestazione, quindi sono necessari carichi individuali adeguati; inoltre il carico deve obbligatoriamente tenere conto dei seguenti parametri:
- Intensità: (la grandezza/forza dello stimolo se debole non è allenante; per esempio, ripetute ad un ritmo troppo basso o carichi troppo deboli).
- Durata: (lo stimolo deve avere una durata allenante: al di sotto non mi alleno; per esempio, pochi minuti di corsa alla soglia o pochi secondi nella contrazione eccentrica);
- Densità: (giusto rapporto fra fasi di impegno e di recupero; per esempio, pause troppo lunghe fra le ripetute);
- Volume: (un adeguato numero e un’adeguata durata degli stimoli allenanti);
- Frequenza: (un giusto numero di allenamenti settimanali).
Il carico di lavoro costituisce l’insieme delle sollecitazioni funzionali, di tipo fisico, tecnico, tattico e psicologico, a cui l’atleta viene sottoposto durante il processo di allenamento.
Primo metodo di valutazione
La formula che viene più frequentemente utilizzata dai metodologi dell’allenamento è:
Carico di allenamento = Quantità x Intensità
Load = Volume x Intensity
(Matvedejev 1960; Harre 1972, Banister1975;)
Performance= Fitness – Fatigue
(Banister 1975)
La quantità (o volume di allenamento) viene valutata attraverso le unità di misura specifiche dell’attività considerata (es. nel caso della corsa i metri o i Km, nel caso della forza il totale dei Kg sollevati o il numero delle serie ecc..). Diciamo che il parametro quantità nel caso dell’allenamento è il più “empirico”, infatti è compito del preparatore o dell’allenatore stabilire la quantità massima di allenamento proponibile.
Per quanto riguarda l’intensità si utilizzano metodi di valutazione differenti, il più semplice, di tipo generale, il primo, è la classificazione da parte dell’allenatore in cinque livelli differenti:
-
leggera
-
media
-
forte
-
intensa
-
massimale
Il limite di questo metodo è determinato dalla “soggettività”, dalla maggiore o minore “sensibilità” del tecnico nel valutare correttamente il livello di intensità del lavoro proposto.
Secondo metodo di valutazione
Il secondo metodo di valutazione prevede una catalogazione di “intensità relativa”, ossia una classificazione dell’intensità in percentuale rispetto ad un parametro di riferimento ben conosciuto. Nel caso dell’allenamento di resistenza, per esempio, i parametri che si possono utilizzare sono quattro:
-
La frequenza cardiaca massima (Fcmax)
-
La velocità aerobica massimale (VAM)
-
La velocità di Soglia Anaerobica (Vobla)
-
La velocità record sulla distanza
di forza si utilizza il carico massimale (il carico con il quale si riesce ad effettuare una sola ripetizione).
Terzo metodo di valutazione
Infine il terzo metodo è rappresentato dal controllo dell’allenamento mediante scale dello sforzo percepito (Borg) e analisi dei tracciati della Frequenza Cardiaca dell’allenamento svolto (Edwards, Banister, Lucia):
-
Scala di Borg, esistono due tipi: 1) la RPE (ratings perceived exertion) che si basa su 20 livelli (da 1 a 20), ma che di fatto parte dal livello 6; 2) CR 10 (category ratio anchored at number 10) che si basa su 10 livelli.
-
Metodo Edwards Training Load ( 5 zone di frequenza cardiaca)
-
Metodo Banister (TRIMP, Training Impulse)
-
Metodo Lucia
Inoltre possiamo aggiungere altri tre metodi per il controllo dell’allenamento (carico interno), che riguardano l’analisi dello stato di recupero del soggetto: La scala TQR (Total Quality of Recovery), la scala TReS del recupero e disponibilità all’allenamento e la HRV (Heart Rate Variability), mediante l’utilizzo di differenti sistemi elettronici di rilevazione della frequenza cardiaca a riposo e analisi con software dedicato.
In ultima analisi ricordiamo anche la Scala VAS (Visual Analogic Scale) la Scala del dolore, anch’essa molto utile in sede di programmazione.
Tali metodi saranno trattati adeguatamente negli articoli successivi, facendo riferimento alla modalità di utilizzo e alla loro applicazione pratica.
Possiamo dire che ci consentono di monitorare l’allenamento in maniera dettagliata, valutando in maniera soggettiva la percezione dello sforzo e quindi l’intensità del carico da somministrare al nostro atleta.
Le sei regole da rispettare per organizzare un carico di allenamento sono:
-
Principio della progressività del carico
-
Principio della continuità del carico
-
Principio della periodizzazione del carico
-
Principio della variazione del carico
-
Principio della successione razionale dei carichi
-
Principio dell’efficacia del carico
Tutto ciò può sembrare semplice e scontato, in realtà se non applicato con i dovuti criteri all’allenamento, la programmazione che se ne evince è puramente inutile e banale. Bisogna inoltre essere consapevoli di non eccedere in maniera disorganizzata nell’utilizzo di queste scale soggettive e stabilire un corretto utilizzo di queste ultime. Pre allenamento scala del recupero (TQR o TReS), post allenamento Scala di Borg CR-10.
Durante l’allenamento (che vedremo negli articoli successivi), se possibile, in base alla disponibilità della società e del preparatore fisico utilizzare cardiofrequenzimetri con fasce di memoria e GPS (carico esterno), per analisi della prestazione. Ove possibile effettuare anche l’analisi della performance fisica e tecnico tattica in partita mediante video match analysis (carico esterno).
In sostanza abbiamo molte possibilità di analisi della performance sia in allenamento che in partita ciò che è importante notare che sia per i dilettanti che per i professionisti ci sono differenti metodi che ci permettono (con poche o molte spese) di valutare il carico di allenamento interno ed esterno con una corretta valutazione del lavoro svolto.
Bibliografia:
1. AA.VV. “L’allenamento fisico nel calcio: concetti e principi metodologici”, Ed.Correre, 2010
2. Iaia FM, Rampinini E, Bangsbo J. High–intensity training in football. Int J Sports Physiol Perform. Sep;4(3):291-306. Review. 2009
3. Impellizzeri FM, Rampinini E, Coutts A, Sassi A, Marcora S Use of RPE-based training load in soccer Med Sci Sports Exer, Vol.36, No. 6 pp 1042-1047 2004
4. Impellizzeri FM, Rampinini E, Marcora SM. Physiological assessment of aerobic training in soccer. J Sports Sci.Jun;23(6):583-92. 2005
5. Impellizzeri FM, Marcora SM, Castagna C, Reilly T, Sassi A, Iaia FM, Rampinini E. Physiological and performance effects of generic versus specific aerobic training in soccer players. Int J Sports Med. Jun;27(6):483-92. 2006